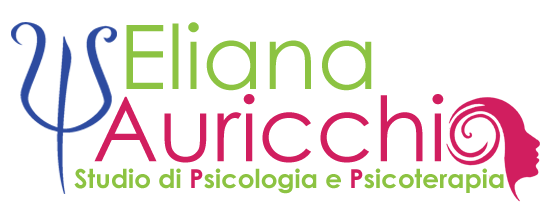La terza età: un’età da abitare
“La rappresentazione sociale più diffusa della condizione anziana è associata, al di là del dato anagrafico, all’idea di un generale processo di decadimento, derivante da una progressiva perdita delle funzionalità psico-fisiche, sociali e produttive del soggetto. Essa veicola una connotazione prevalentemente critica di questa fase dell’esistenza: i tratti che più frequentemente si attribuiscono alle persone anziane sono infatti quelli di debolezza, fragilità, dipendenza, disimpegno e inutilità”. Come ironicamente scrive Woody Allen: “Non c’è niente di vantaggioso nell’invecchiare. Non diventi più gentile o più saggio, hai solo problemi di stomaco e di udito”.
Ad un’analisi più accurata si comprende come questa immagine sia piuttosto un clichè o uno stereotipo che poco colgono la complessità e la dinamicità di questa fase del ciclo vitale.
Gli studi e la letteratura sull’argomento hanno invece fatto emergere la necessità di rileggere la terza (e quarta) età secondo una logica diversa, che tenga conto delle molteplici risorse e potenzialità che caratterizzano oggi l’anziano e soprattutto, la grande variabilità dei percorsi di invecchiamento. Percorsi che molto dipendono dalle condizioni socio-strutturali in cui l’individuo è inserito e dall’insieme delle relazioni familiari e sociali cui egli partecipa.
Insomma all’immagine monolitica del vecchio fragile e passivo si è sostituita una visione dinamica che riconsidera la terza età come una transizione lunga e complessa, che racchiude diversi snodi e passaggi critici, ma anche tempi di benessere e buona salute.
Se si considera poi l’anziano come membro di un sistema familiare, inserito all’interno di relazioni affettive significative (con altri componenti che a loro volta stanno affrontando passaggi altrettanto importanti del ciclo vitale), l’ottica della complessità è fondamentale e ci aiuta a comprendere meglio le caratteristiche di questo periodo.
La vecchiaia allora è un luogo da abitare ma anche da inventare, sia socialmente che individualmente.
Gli eventi che costituiscono i “marcatori di ingresso” della condizione anziana sono:
L’esperienza di “nido vuoto”. Compiti evolutivi
- Ai membri della coppia, in quanto coniugi, sono richiesti una rinegoziazione e un reinvestimento nella relazione di coppia
- In quanto genitori, la capacità di rinegoziare il rapporto con i figli in base al comune status di adulti, accogliendo nello spazio familiare nuovi componenti (nuore e generi)
- Obiettivo comune a genitori e figli è l’interdipendenza: continuare a mantenere una relazione reciproca
Il pensionamento. Compiti evolutivi:
a) Svolgere una funzione di generatività sociale: l’anziano mette a disposizione il suo tempo e le sue competenze per promuovere progetti e interventi di sostegno alle generazioni più giovani
b) Tornare a coltivare la relazione con fratelli e amici
- Reinvestire nella coppia coniugale: i coniugi devono ricercare un nuovo adattamento e ridefinire i reciproci compiti e gli spazi individuali
Diventare nonni. Compiti evolutivi:
- “Spostarsi indietro di una posizione”: riconoscere i propri figli come genitori “capaci”, aiutandoli senza sostituirsi a loro
- Instaurare con i propri figli una “intimità a distanza”, una sintesi fra vicinanza e distacco, fra autonomia relazionale e coinvolgimento affettivo
- Affrontare il passaggio delle generazioni
- Impegnarsi a esprimere e comunicare in modo vitale il patrimonio familiare
La malattia. Compiti evolutivi:
- Accettare l’aiuto fornito dal coniuge, dai figli e dalle loro famiglie
- Mantenere gli aspetti di vitalità contrastando la passività
- Fornire cure e collaborare con il sistema dei servizi – la cura della riconoscenza e lealtà filiale (dal punto di vista dei figli)
Affrontare la morte
La morte è la transizione più difficile da affrontare e mette profondamente alla prova le relazioni familiari
Compiti evolutivi:
- Affrontare il distacco e la perdita del coniuge e prepararsi alla propria scomparsa (per l’anziano)
- Condividere l’esperienza del dolore e coltivare la cura del ricordo (per il coniuge rimasto in vita e i familiari): la morte non è un’interruzione totale ma un’eredità da raccogliere.
Tali momenti critici sono fisiologici e caratterizzanti l’ultima fase del ciclo vitale. Può accadere, talvolta, che essi si rivelino particolarmente complessi e dolorosi per l’anziano e per tutto il sistema familiare, agendo da pericolosi detonatori di nodi problematici da tempo latenti.
Il ruolo dello psicologo può essere particolarmente utile soprattutto in queste situazioni: aiuto all’individuo e alla famiglia nella gestione della criticità e nel trasformare tali “prove” in occasioni di crescita e bonifica delle relazioni. Cura dell’anziano ma soprattutto cura dei legami.
Il Mito di Cura
Mentre Cura stava attraversando un fiume vide del fango argilloso.
Lo raccolse pensosa e cominciò a dargli forma. Ora mentre stava riflettendo su ciò che aveva fatto, si avvicinò Giove.
Cura gli chiese di dare lo spirito di vita a ciò che aveva fatto e Giove acconsentì volentieri. Ma quando Cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il suo nome.
Mentre Cura e Giove disputavano sul nome intervenne anche Terra reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché essa, la terra, gli aveva dato parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice, il quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione:
“ Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito. Tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che esso vive lo possiede Cura. Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è stato tratto da humus”.
( Il mito di Cura, Liber Fabularum, II sec. d.C.)
Il mito di Cura spiega magistralmente il ruolo dello psicologo nella fase della vecchiaia: finché l’uomo è in vita lo possiede Cura, anche nei casi di quelle malattie tipiche dell’ultima transizione (ad esempio le Demenze) a volte inguaribili ma non incurabili.
Riferimenti bibliografici:
Olievenstein C., La scoperta della vecchiaia. Einaudi, 1999
Scabini E., Cigoli V., Il famigliare. Legami, simboli e transizioni. Raffaello Cortina editore, 2000 Tamanza G., Anziani. Rappresentazioni e transizioni dell’ultima età della vita. FrancoAngeli, 2001