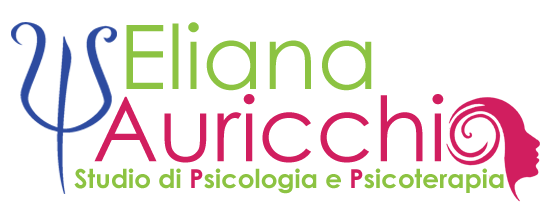Adolescenza
Rendimi il tempo della mia adolescenza
Quando ancora non ero me stesso, se non come attesa.
Rendimi quei desideri che mi tormentavano la vita,
Quelle pene strazianti che pure adesso rimpiango.
La mia giovinezza!…Basta. sappi rianimare in me
La forza dell’odio, il potere dell’amore.
Goethe, Faust
L’adolescenza è un’età di frontiera dai confini sempre più labili; mutevole, imprevedibile, incerta. Il suo percorso tende a iniziare prima, con una pubertà sempre più precoce rispetto al passato, che si colloca generalmente fra gli undici e i tredici anni. Ma se il suo inizio è segnato da una data precisa, un evento fisiologico, l’approdo all’età adulta viene rinviato sempre di più nel tempo, fino a far apparire interminabile questa lunga fase di transizione.
A differenza di quanto avveniva nell’infanzia, allo sviluppo sessuale e intellettuale dell’adolescente non corrisponde quasi mai un’analoga maturazione emotiva e affettiva. Ed è in questo scarto, tra un corpo e un cervello già formati, da adulti, e un mondo interiore ancora dominato da sentimenti infantili, che si giocano i conflitti, i desideri, le ansie e le paure di una età all’insegna della contraddizione. L’adolescente è in bilico tra un passato che tende a rinnegare, ma di cui ha ancora tanta nostalgia e un futuro che appare vago, misterioso, e soprattutto privo di certezze. La spinta biologica verso la maturità è frenata da profonde incertezze interiori che fanno procedere a sbalzi, alternando la corsa in avanti con improvvise fasi di immobilità o di regressione. Oggi tali incertezze anziché sostenute e arginate dal mondo adulto, sono da quest’ultimo ulteriormente amplificate, proprio perché gli stessi adulti vivono una condizione di precarietà, conservando loro stessi molti aspetti “adolescenziali” con poche certezze e sicurezze da offrire alle nuove generazioni.
Possiamo identificare in questa fase dello sviluppo momenti evolutivi caratteristici:
- Un nuovo modo di pensare. L’ingresso nell’età puberale coincide con un nuovo modo di ragionare, più astratto e razionale: si assiste al passaggio da un tipo di pensiero operativo-concreto ad uno astratto-ipotetico-deduttivo ( come hanno ben illustrato gli psicologi cognitivisti Piaget e Inhalder). Dai dieci anni in poi i bambini sono in grado di utilizzare processi logici che consentono di cogliere nessi e corrispondenze al di là delle differenze superficiali, di stabilire una catena di sequenze fra causa ed effetto; di prendere in considerazione numerosi fattori contemporaneamente, valutando diverse ipotesi. La capacità di pensare in termini astratti, non per forza ancorati alla realtà e alla concretezza, oltre a riverberarsi sull’apprendimento scolastico, si riflette anche nel modo di gestire le relazioni intellettive con gli altri. Anche in famiglia, qualsiasi argomento venga affrontato con i figli ora può essere fonte di impegnative discussioni; i genitori si trovano di fronte un interlocutore che difende le proprie idee utilizzando argomenti complessi e originali, che spesso si interessa di grandi temi filosofici ed esistenziali. Sebbene anche in questa fase non manchino conflitti da superare, questo nuovo modo di ragionare costituisce una vera ancora di salvezza mentale in un periodo di grandi sconvolgimenti fisici ed emotivi: la maturazione intellettiva sostiene l’adolescente quasi come una zattera nella tempesta della improvvisa modificazione del corpo con l’emergere di intense e nuove pulsioni sessuali,e contemporaneamente con la tendenza a tornare indietro verso posizioni vecchie e pregenitali dello sviluppo. Le nuove capacità cognitive sono fondamentali anche nella ricostruzione dell’immagine corporea, aiutando il bambino a collegare e integrare le trasformazioni fisiche in atto in nuove rappresentazioni mentali, arginando così l’ansia e lo spavento che egli prova in seguito a tale metamorfosi.
- Un corpo che cambia. Il corpo dell’adolescente si modifica in modo nuovo, imprevedibile comportando un conseguente cambiamento dello schema corporeo e dell’immagine che il soggetto ha di sé. Tale metamorfosi a volte provoca un sentimento di estraniamento, come se tutte queste trasformazioni non fossero più sotto il suo controllo e la sua capacità di elaborazione mentale generando ansia e angoscia. Il conflitto principale che accompagna questa età è lo squilibrio fra una maturità corporea ( l’adolescente è biologicamente in grado di procreare) ed una immaturità psichica. Questo corpo imprevedibile, che sembra sfuggire a un controllo e ad una comprensione genera molta ansia attivando nel ragazzo bisogni di controllo spesso proiettati all’esterno: attenzione spesso ossessiva alla cura di sé e del proprio aspetto fisico, ai propri oggetti, alla “cameretta”, fino a comportamenti di stampo ossessivo come i rituali e le piccole manie che hanno lo scopo inconscio di ripristinare un ordine nel caos di cambiamenti ed emozioni; interesse per giochi e hobby che riflettono tale desiderio di ordine e organizzazione.
- Il rapporto con i genitori. Il tema della separazione-individuazione rappresenta un nodo cruciale in questa fase del ciclo vitale, un processo che riguarda sia il singolo che il sistema cui appartiene. Il punto di vista sistemico-relazionale ci aiuta a capire come l’adolescenza non sia una fase complessa solo per il ragazzo che la sta vivendo ma un evento critico per l’intera famiglia che è posta di fronte al compito di ristrutturare e riorganizzare regole, confini e relazioni. Ad esempio: aumentare la flessibilità delle regole; modificare la relazione genitori-figli per consentire a questi ultimi di entrare e uscire dal sistema; modificare la relazione coniugale; modificare gli interessi personali di ciascun coniuge singolarmente. Il compito della individuazione e separazione richiede il massimo sforzo da parte sia dei figli che dei genitori. L’adolescente deve rinunciare alla sua dipendenza infantile dalle figure genitoriali, ma anche all’immagine idealizzata che aveva di questi: si assiste ad una vera e propria “caduta degli dei”; alla immagine di genitori onnipotenti e infallibili si arriverebbe pian piano, attraverso rabbia e contestazioni, ad una visione più realistica di genitori umani, non privi di difetti, debolezze e incongruenze. Il punto di arrivo di questa fase dialettica è la disillusione: il passaggio dalla idealizzazione dei genitori alla capacità di accettarli “così come sono”, sostituendo la realtà alle illusioni infantili. Naturalmente i genitori devono accettare la sfida lanciata dal figlio, sopravvivere ai suoi attacchi aggressivi rimanendo al loro posto. Come scriveva D.Winnicott, noto psicoanalista infantile: “Dove c’è un ragazzo che lancia la sua sfida per crescere, là deve esserci un adulto pronto a raccoglierla”. È sbagliato credere che chi alleva bene i figli da piccoli non avrà difficoltà quando saranno adolescenti: una protesta costruttiva, funzionale all’affermazione di sé, è il risultato di sicurezza e fiducia acquisite dai figli nell’infanzia.
- L’importanza del “branco”. L’adolescente alle prese con il compito della differenziazione e affermazione di una propria identità, cerca fuori dalla famiglia nuove esperienze, nuovi modelli comportamentali, nuove identificazioni che possano permettergli di staccarsi dai genitori, trovandole nel gruppo dei coetanei. Una seconda famiglia in cui riconoscersi e dalla quale essere riconosciuti, sviluppando un senso di appartenenza che protegge dalla solitudine. Il gruppo con le sue dinamiche molto intense, chiuso agli adulti, è fondamentale nel permettere ai ragazzi di sperimentare le loro capacità di stare insieme, di condividere obiettivi, misurare le proprie capacità intellettuali, fisiche e sociali.
La complessità della fase adolescenziale la rende particolarmente a rischio per l’insorgenza di alcune patologie che possono esordire specificamente in questo periodo. È importante sottolineare come tali problematiche, avendo l’adolescenza un carattere indefinito e transitorio, non abbiano un carattere strutturato e di cronicità ma siano in continua evoluzione. Pertanto ogni sintomo, in questa fase, acquista un significato assolutamente evolutivo.
Alcune patologie a insorgenza adolescenziale:
- Tentativi di suicidio
- Promiscuità sessuale
- Disturbi del comportamento alimentare
- Break down adolescenziale
- tossicodipendenza
Riferimenti bibliografici:
M. Malagoli Togliatti, U. Telfener. Dall’individuo al sistema. Bollati Boringhieri, 1995
D. Marcelli, A. Braconnier. Adolescenza e psicopatologia. Biblioteca medica Masson, 1996
S. Vegetti Finzi, A.M.Battistin. L’età incerta, i nuovi adolescenti. Mondadori, 2000